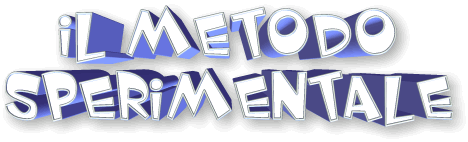|
Nell’indagine della natura gli scienziati antichi non seguono il metodo sperimentale, che è stato teorizzato nel 1600 da Galileo Galilei (1564–1642) e che è tuttora il metodo della scienza per giungere alla formulazione delle leggi scientifiche. Il metodo sperimentale comprende quattro momenti fondamentali:
L’introduzione dell’esperimento e dello stretto rapporto tra ipotesi ed esperimento è una grande novità. Nelle loro ricerche gli scienziati antichi non trascuravano l’osservazione dei fatti e raccoglievano i dati dell’esperienza in maniera scrupolosa (basti pensare alla medicina cnidia e ippocratica), ma non presentavano poi le loro interpretazioni dei dati come ipotesi da verificare, bensì come spiegazioni certe dei fenomeni dell’ambito che era oggetto delle loro indagini. Il metodo scientifico degli antichi era quindi induttivo, poiché risaliva alla legge generale dall’osservazione dei casi particolari, ma non era sperimentale così come si intende da Galileo in poi. Ciononostante si possono trovare esempi di un certo sperimentalismo nei Pitagorici e in Empedocle.
|