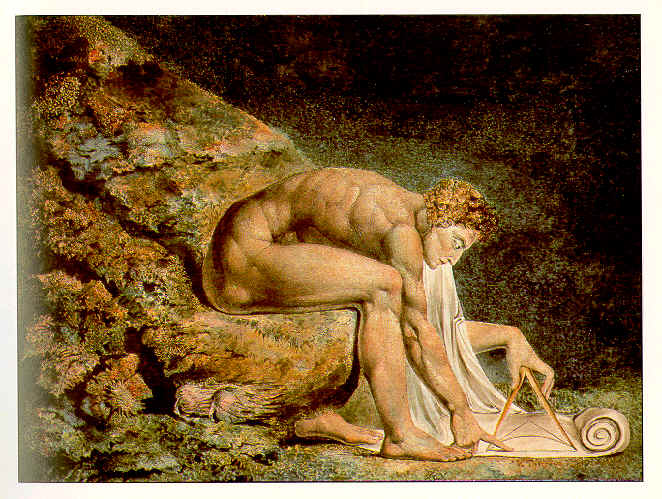UNA
NUOVA LOGICA E UNA NUOVA FISICA
O UNA NUOVA METAFISICA?
L’emancipazione
della scienza dalla filosofia è basata su una sostituzione e su una distinzione:
La logica matematica
sostituisce la logica categoriale;
la prima è logica
(ordine, linguaggio,discorso) della natura, la seconda dell'essere
(metafisico)
Galilei è un
matematico e (perciò) un filosofo naturale, un fisico
(=MATEMATISMO GALILEIANO)
L’intensità della rottura non può
però far dimenticare un’importante linea di continuità. Qual è, infatti, il
fondamento di quell’ " e ",
di quel
" perciò " che lega il matematico al fisico
?
E’ l’idea aristotelica della perfetta corrispondenza tra
strutture metafisiche (sostanziali) del
reale,
strutture logiche (categoriali) del pensiero,
strutture semantiche del linguaggio.
Ovvero l’idea, non solo
aristotelica ma anche platonica, cristiana, insomma classica, premoderna (precartesiana)
del logos come ordine
insieme del linguaggio, del
pensiero, della realtà
Dicendo che il libro della natura
è scritto in caratteri matematici, Galilei ripristina nella sua indubitabilità
la corrispondenza tra
PENSIERO
ed ESSERE,
logica
(matematica) e realtà (naturale).
| Mentre per
tutte le altre forme di discorso, pensiero, logica, la realtà resta
al di là (tanto che esse rimangono forme o vuote o
inadeguate, concetti che o non stringono realtà alcuna o non vi
corrispondono) |
|
|
[non
posso conoscere le strutture fondamentali della realtà] |
| alla
matematica è garantita una corrispondenza reale, una presa sulla realtà,
un contenuto, un valore di verità |
| |
[posso
conoscere le strutture fondamentali (matematiche) della realtà] |
Quale ragione sostiene questa "
eccezionalità " della matematica ?
Il fondamento ultimo è ancora
il VERBO, il LOGOS (matematico) divino che ha scritto il Libro
della natura in caratteri matematici e
dotato la ragione dell’uomo di un
linguaggio matematico.
Lo sfondo resta dunque quello
stesso della concezione classica del logos: non è nato un nuovo
orizzonte, si è solo prodotta una
modificazione – benché sostanziale – in un
quadro che non ha mutato le su coordinate chiave.
La vecchia alleanza tra
religione e filosofia, messaggio cristiano e sapienza greca, teologia e
metafisica, è sciolta, a tutto
vantaggio della scienza che la ricompone a suo
favore, approfittandone, tra l’altro, per togliere ogni ruolo alla filosofia,
stretta
tra
le soluzioni etico – religiose della BIBBIA
e quelle conoscitive del LIBRO DELLA NATURA
L’altra faccia della medaglia (o
il prezzo che doveva necessariamente essere pagato) è la paradossale
nascita
della scienza moderna in un contesto premoderno
e quindi ambiguo, o non del
tutto consequenziale, in quanto costretto a " fare eccezione ", incapace di
trarre le estreme
conseguenze
dalle sue stesse premesse: quelle, ribadite a viva
forza dall’itinerario gnoseologico del pensiero moderno, dell’irrimediabile
separazione
tra la realtà in sé e la sua rappresentazione, dell’irricucibile
strappo tra essere e pensiero.
|
Dobbiamo
a R. Descartes, iniziatore dell’itinerario gnoseologico
del pensiero moderno, il riconoscimento della opposizione tra pensiero
ed essere (che altro non è se non la consapevolezza del carattere
soggettivo del nostro mondo) |
 |
|
 |
ad
I. Kant, a conclusione di esso, il riconoscimento di
quella stessa opposizione come non più ricomponibile, definitiva. |
In quel
contesto la presenza di Galilei spicca come quella di un nuovo metafisico.
Da non dimenticare,
inoltre, le conseguenze che derivano dal passaggio del compasso dalle mani di
Dio alle mani dell’uomo.
Non emerge qui evidentemente il
carattere laico, se non ereticale, o addirittura profanatore, di un sapere che
voleva (o doveva) sorgere in
perfetta
armonia con il messaggio
cristiano? [per un approfondimento cfr. C 2-3]
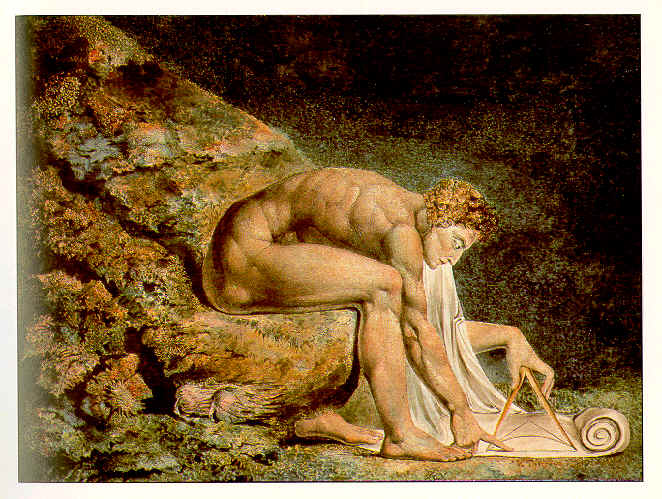
Il Newton di William
Blake