RAVENSBRÜCK
Lidia
Beccara Rolfi, A. Maria Bruzzone- “Le donne di Ravensbrück” Einaudi, 1978
Dall’introduzione di Bruzzone
 Ravensbrück,
come tutti i campi di stermino, è strutturato in modo non dissimile dalle
città, e dalle società, in cui siamo abituati a vivere. La popolazione delle
deportate è divisa in classi, che sono tenute lontane le une dalle altre in
conformità a questa divisione. Ci sono le “sottoproletarie”, le
“proletarie”, le “borghesi”.
Ravensbrück,
come tutti i campi di stermino, è strutturato in modo non dissimile dalle
città, e dalle società, in cui siamo abituati a vivere. La popolazione delle
deportate è divisa in classi, che sono tenute lontane le une dalle altre in
conformità a questa divisione. Ci sono le “sottoproletarie”, le
“proletarie”, le “borghesi”.
I sopravvissuti dai lager nazisti trovarono al ritorno in patria una
condizione di vita non abbastanza diversa da quella che lasciavano: la corsa
feroce al potere e ai beni materiali di tanti che al momento del pericolo
erano stati rintanati al sicuro, il rientro graduale nelle loro posizioni
privilegiate degli autori delle sciagure che avevano colpito gran parte
dell’umanità, ingiustizie e diseguaglianze non scalfite dalla Liberazione,
gli ex deportati abbandonati a se stessi.
I Lager non sono mai scomparsi. Sono semmai più
raffinati ed efficaci. Anche nelle società cosiddette democratiche ne
esistono tracce più o meno evidenti, mai accidentali e casuali: gli ospedali
psichiatrici, i bretotrofi, i ricoveri per vecchi, i riformatori, le
carceri, l’esercito, le fabbriche, chi ha tutto e troppi che non hanno
nulla.
Spesso nei discorsi ufficiali e un po’ pomposi sui lager si sente dire:
“perché non si ripeta”. Invece non è mai finito: i presupposti del lager sono
dappertutto. La resistenza dentro ai lager ci può forse dare delle
indicazioni, perché forse il lager e il suo modo di “ragionare”-
niente a che fare con l’irrazionalità, ma un progetto coerente- è quello che
più assomiglia alla vita del globo nel momento attuale.
Resistenza umana.
E resistenza non solo umana, perché forse è venuto il momento anche di non
considerare la nostra specie il centro dell’universo, di mettersi un po’ da
parte, di non voler più assomigliare agli dei, di fermarsi dal fabbricare e
produrre, di non “progredire” più. Resistenza per mantenersi sensibili. Ma
resistenza reale, che inceppi i meccanismi.
Se tante cose nelle tante storie che ho letto di queste donne che hanno
combattuto durante la Resistenza sono legate a un’epoca e se perfino alcune mi
sembrano cose che fanno parte anch’esse di un sistema che rifiuto- per esempio
questa loro pazzesca etica del lavoro, l’orgoglio di lavorare in una grande
fabbrica come la FIAT, sono cose incomprensibili per me che sono cresciuta
politicamente all’ombra del rifiuto del lavoro, intendendo come lavoro non
l’attività umana, ma il lavoro coatto e alienato, cose comprensibili solo se
legate a quel contesto storico (il lavoro per le donne è stato senz’altro
portatore di indipendenza e autonomia), ma pericolose oggi (forse anche ieri).
Oppure la fede cieca e l’obbedienza al partito che si trova in alcune di loro.
O questo concetto di “patria”,
sempre comprensibile in quel momento ma foriero di nazionalismo e chiusura in
altri contesti. C’è qualcosa (molto) invece che ci parla anche oggi. Sono le
cose forse più universalmente umane? O è forse al contrario il ribadire che ci
sono delle classi sociali. Il ricordarci che la lotta è di classe? O tutte e
due le cose. È la ribellione, il non arrendersi alla prepotenza, lo spirito di
libertà che anima molte di loro quello che mi tocca di più. Mi piace quando
dicono “l’idea”. È l’agire, il non sottrarsi alla necessità di agire.
Sarebbe bello non dover parlare ancora di resistenza, ma di qualcosa di più-
costruzione di una vita diversa- ma qui ci troviamo, ancora a resistere, a
combattere contro poteri forti, reali e materiali. Che sono sempre gli stessi,
ma anche diversi. Le risposte che vanno cercate sono metodi per destrutturare
e distruggere questi poteri, l’alternativa violenza-non violenza è un falso
problema, anche questo ci dicono queste donne. Il problema è invece trovare
modi efficaci. Dicono che usare la violenza significa diventare come il potere
che si combatte. Le storie, i destini, le parole e il sentimento di queste
donne sembrano smentirlo.
Per loro agire è
stata semplicemente una necessità.
Forse è invece il ricercare potere quello che ci può rendere simili al potere
e far tornare la ruota al punto di partenza. Se c’è qualcosa da mettere in
discussione della storia del novecento, per quel che riguarda la nostra parte,
non è questo (falso) problema dei metodi più o meno violenti, è invece,
secondo me, la questione del potere, delle gerarchie, del centralismo, del
partito, del militarismo, dell’obbedienza, della necessità di avere dei capi,
della rappresentanza.
E tocca purtroppo ancora ribadire che
una cosa è la violenza del carnefice e un’altra quella di chi si ribella alla
carneficina.
Il passato ci interessa per le sue
connessioni con il presente e per l’ombra che getta sul futuro.
Lidia Beccaria Rolfi
Ravensbrück è l’unico lager
nazista esclusivamente femminile.
È stato costruito all’inizio del ’39 e si trova a 80 km a nord di Berlino,
sulla riva del lago di Furstenberg.
Le prime 867 deportate sono tutte tedesche. Sono comuniste,
socialdemocratiche, antinaziste in genere, o appartenenti ai testimoni di
Geova, setta pacifica e contraria al regime della violenza.
All’inizio lo scopo del campo è quello di
“rieducare”
attraverso la disciplina,
la pulizia e il lavoro. I letti sono tutti uguali, ogni armadio è uguale
all’altro, gamella e bicchiere devono brillare come specchi, gli sgabelli
devono essere allineati al centimetro, il pavimento lavato più volte al
giorno, i letti rifatti con precisione assoluta. Il lavoro è lavoro inutile,
come ammucchiare per otto ore dune di sabbia e il giorno dopo spianarle per
altre otto ore. Ogni minima infrazione al regolamento è punita severamente.
Nell’estate del ’39 arriva il primo trasporto di zingare con bambini, poi via
via arrivano austriache, cecoslovacche, polacche, olandesi, norvegesi. Fra di
loro alcune ebree e molte testimoni di Geova.
Nel ’41 l’organizzazione SS scopre che il lavoro rieducativo può diventare
anche produttivo. Si stabilisce un
rapporto economico-commerciale fra l’industria tedesca e l’amministrazione SS
dei campi. Le deportate di Ravensbrück
vengono affittate ad industrie e fattorie. L’industriale SS Opitz impone da
subito 12 ore di lavoro ininterrotto al giorno, il turno di notte e ottiene
l’aumento costante della produzione con il terrore.
Le più deboli e le più anziane divengono materiale non utilizzabile. Si
iniziano le selezioni, i “trasporti
neri”, così verranno chiamati i
trasporti destinati al gas. I Lager diventano campi di sterminio per mezzo del
lavoro.
All’inizio del ’43 arrivano numerosi trasporti soprattutto dalla Russia.
Arriva anche, il 30 giugno del ’44, il primo trasporto di italiane, 14 in
tutto.
Ravensbrück è circondata da un muro altissimo, su cui corrono i fili dell’alta
tensione, agli angoli ci sono torrette di guardia con le mitragliatrici
puntate. All’interno una città soffocata
e compressa, senza un filo d’erba, senza un
albero, con i servizi essenziali: cucina, ospedale da campo, prigione e
crematorio, con due grandi aree industriali periferiche e abitazioni costruite
a misura del sistema che ha bisogno di ammassare il maggior numero di schiave
nel minor spazio possibile per
comprimere i costi e aumentare i
profitti. Una città dormitorio che,
nella sua feroce funzionalità della produzione, ricorda le nostre città
industriali.
Il cerimoniale dell’arrivo al campo è
sempre lo stesso: inizia con una sosta d’attesa, che serve per aumentare la
tensione, che dura fino al mattino successivo. Al mattino le deportate devono
spogliarsi nude, lasciare tutti gli effetti personali, sono rapate, frugate, a
volte perquisite nelle parti più intime, avviate alle docce e poi spinte
fuori, ad asciugarsi sotto il sole o la neve. Prima la divisa era a strisce
grigie e blu, ma nel ’44 è ormai un lusso concesso alle vecchie del campo. Le
prigioniere vengono rivestite con stracci, con una grossa croce dipinta
davanti e di dietro. Questi stracci sono la divisa d’obbligo delle deportate
in quarantena,
condannano le ultime arrivate a una
condizione di sottoproletariato. Per l’abbigliamento non si fa questione di
numero o di taglie. Le scarpe possono avere tacchi diversi, essere due destre
o due sinistre, purchè siano due. Pettine, spazzolino, fazzoletti, pannolini,
forcine, ago, ecc. sono sottratti come inutili. La mancanza di tutto occupa
nei primi giorni tutte le energie delle nuove arrivate, la ricerca impegna
tutto il tempo e non lascia riflettere sulla realtà concentrazionaria, quando
ci sarebbero ancora le energie per pensare.
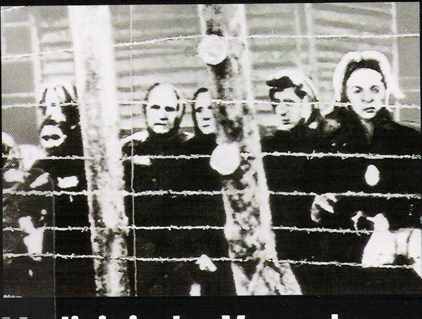
Il mio trasposto è assegnato
al blocco 24. I block sono costruzioni di legno incatramato, divisi in due
Stube, in ognuna delle quali ci sono un refettorio, un dormitorio, tre
lavabi e tre latrine. La blockowa e la stubowa sono le responsabili
rispettivamente del block e della Stuba, entrambe sono deportate. Il
refettorio è così affollato che le deportate si accalcano anche sotto e
sopra i tavoli, pigiate in piedi, senza poter fare un gesto e un movimento.
Le gamelle non sono sufficienti per tutte, occorre aspettare che il primo
turno finisca per afferrarne una al volo e mettersi in coda con la gamella
sporca. La sbobba è una brodaglia insipida e dolciastra, molto liquida, che
dobbiamo mangiare senza cucchiaio. Il leccare la minestra come i cani
avvilisce,
fa sentire bestie
molto più di altre cose. La logica del
sistema vuole proprio questo: ridurre le deportate alla condizione di bestie
da lavoro docili e ubbidienti. Imparo a leccare la minestra nella gamella
sporca, usata prima da una sconosciuta. Lecco la zuppa immonda fin dal primo
giorno.
Il dormitorio è completamente occupato da letti a castello a tre piani, lo
spazio tra i piani è così poco che da sedute le prigioniere battono la testa
contro le assi. Ogni letto, non più largo di 70, 80 cm, è destinato a due o
anche tre deportate per posto. Ricordano all’aspetto i ripiani per i bachi
da seta: li ricordano anche nel brusio ininterrotto di larve umane che da
essi si leva, li ricordano soprattutto nella puzza insopportabile che emana
da centinaia di corpi mal lavati. Nonostante l’ambiente mi addormento di
colpo, dopo quattro giorni di vagone bestiame e una notte passata nel locale
delle docce.
Per la città concentrazionaria quarantena vuol dire soprattutto allenamento
alle situazioni impossibili. Fin dal primo giorno le deportate si adeguano,
non tanto per paura, quanto perché il pianeta su cui sono catapultate non gli
permette, almeno all’inizio, di riflettere, di pensare, di analizzare
lucidamente la situazione, sono soggiogate dall’atmosfera assurda e grottesca
del blocco.
La giornata nel blocco inizia alle 3,30 con il fischio della sirena. In
mezz’ora bisogna scendere dal letto, infilarsi il vestito, rifare il letto
alla perfezione secondo il regolamento, andare a lavarsi, fare la coda alla
latrina e schierarsi, dieci per dieci, sulla Strasse davanti al blocco. Nei
primi giorni è impossibile compiere tutte le operazioni; si va all’appello
senza lavarsi e si rimanda. Rinunciare a lavarsi quotidianamente è il primo
gradino della disumanizzazione, ma poche se ne rendono conto.
L’appello del mattino è una delle tante torture non torture del campo.
Costringe a rimanere in piedi in ranghi di dieci per ore e ore. L’appello si
svolge in posizione di attenti, sotto la pioggia, la neve o il vento.
All’appello è proibito muoversi, parlare con le compagne, accoccolarsi quando
le gambe non reggono più , battere i piedi per riscaldarsi, avere il petto
ricoperto di un pezzo di carta rubata per difendersi dal freddo. Dopo la prima
mezz’ora diventa una tortura. Il cervello si svuota, le gambe si gonfiano, i
piedi fanno male, dolori atroci corrono per tutti i muscoli. L’appello a
Ravensbrück, dove si addestra psicologicamente la manodopera destinata a
lavorare, produrre e rendere nell’industria tedesca, è molto più lungo che non
quello dei sottocampi di lavoro dell’industria stessa.
Occorre un certo
periodo di addestramento per distruggere
nelle persone ogni volontà di resistenza e opposizione e per ridurle in
schiavi docili, disponibili per
qualsiasi tipo di lavoro: l’appello è uno dei mezzi per raggiungere lo scopo.
Quando la quarantena vera e
propria è finita si può partire per un trasporto, se vi è richiesta urgente di
manodopera, oppure la quarantena può prolungarsi, in attesa di destinazione.
Le deportate in questo caso sono trasferite in nuovi blocchi e diventano
Verfugbar, disponibili. Durante la quarantena vengono tenute divise dalla
popolazione stabile del campo e vengono impiegate solo nelle corvèe di lavoro
della vita quotidiana normale, oppure avviate a lavori inutili, come quello
della sabbia. Il lavoro consiste nel prendere una palata di sabbia nel
mucchietto di sinistra e buttarlo in quello di destra dove la compagna di
fianco esegue la stessa operazione. La sabbia viaggia in tondo e torna al
punto di partenza. La deportata che non sa reggere il ritmo viene picchiata
con le mani o con il frustino. Anche questo lavoro senza senso ha uno scopo:
la vita inattiva delle deportate in attesa di destinazione è temuta dalle SS,
perché
può trasformarsi in
un’organizzazione di resistenza alla
disumanizzazione
e in una
scuola di educazione politica.
Fin dal primo giorno è possibile resistere
alle
violenze, se si è informate della vita del
campo e dei motivi per cui il sistema adotta quei metodi, se si prendono
contatti con le più anziane. Noi italiane siamo poche e disperse, e isolate da
tutte le altre, impariamo a nostre spese cosa vuol dire essere cittadine di
uno stato fascista. Non possiamo contare sull’aiuto e la solidarietà di
nessuno e ci mancano così gli strumenti per resistere. Quando incomincio a
parlare francese mi rendo conto come sia diversa la situazione di chi
arrivando trova ad attenderle compagne della stessa nazionalità e fede
politica. Oltre ad aiuti materiali, ricevono informazioni e consigli per
affrontare la vita nel campo e non cadere nel pericolo maggiore, quello di
accettare passivamente il mondo del disumano, lasciarsi andare, rinunciare
anche alla lotta per la sopravvivenza. Ho visto le francesi organizzare
lezioni di storia, geografia, letteratura, animazioni di gruppo con canti,
recitazione, dizione di poesie, tutto in barba agli ordini e in barba alla
stubowa.
L’allenamento alla resistenza si esprime
anche attraverso la
solidarietà
tra compagne dello stesso trasporto. Le
donne più anziane sono assistite, aiutate all’appello, spinte a resistere. Le
più deboli moralmente sono spinte ad assumere comportamenti dignitosi, a non
parlare di fame e di pidocchi, a non rimpiangere il passato.
Il sistema non ha previsto tutto questo né è in grado di soffocarlo. Il
sistema ha un modo solo per spezzare la volontà di resistenza delle deportate:
piegarle con appelli che a volte durano un giorno intero, ammazzarle di
lavoro, distruggerle fisicamente. Questa credo sia la ragione dei lavori
inutili. È preferibile perdere qualche futura unità lavorativa, sempre
facilmente rimpiazzabile, piuttosto che correre il rischio di trovarsi di
fronte delle persone irriducibilmente nemiche e pericolose all’interno del
mondo del lavoro.
Ravensbrück al nostro arrivo è popolato da
prigioniere provenienti da ventitre paesi d’Europa. Il comandante del campo, i
suoi collaboratori, i gregari appartengono alle SS, e anche le sorveglianti
donne sono SS. Al vertice della gerarchia SS che domina il campo c’è un
Lagerkommandant. A capo dell’ufficio del lavoro c’è Pflaum, che ha una
posizione particolare: rappresenta e cura gli interessi economici
dell’Organizzazione commerciale SS, mentre il Lagerkommandant rappresenta gli
interessi politici, l’aspetto ufficiale e poliziesco. Le posizioni dei due
comandanti a volte sono antitetiche, in quanto gli interessi del poliziotto
non sempre coincidono con quelli dell’imprenditore.
Le
donne SS
non hanno posizioni di responsabilità,
svolgono un servizio paragonabile a quello dei secondini. Sono disprezzate da
tutti, sono pagate male e hanno un ritmo di lavoro molto duro. Tuttavia si
compiacciono dei loro stivali, del loro frustino, della divisa che le fa
sentire qualcuno.
Imitano gli uomini,
cercando di superarli in violenza e
ferocia.
L’organizzazione interna e
l’amministrazione della città è invece nelle mani delle prigioniere. Questa
delega del potere è dettata da due motivi: la necessità di risparmiare forze
militari necessarie sul fronte; la possibilità di addebitare alle prigioniere
tutte le violenze che si consumano nel campo. Alla direzione del Lager c’è una
capocampo prigioniera, la Lageralteste, alle sue dipendenze le impiegate, le
blockowe e le stubowe, le kapo, responsabili dei Kommando di lavoro e le
Lagerpolizei, il servizio d’ordine. Queste donne, le “borghesi”, godono di
privilegi non indifferenti. All’inizio vengono reclutate tra le prigioniere
colpevoli di reati comuni (i triangoli verdi, le politiche hanno il triangolo
rosso), sono sempre tedesche. Quando la città cresce vengono assunte in questi
posti anche delle deportate politiche, prima tedesche e poi anche di altre
nazionalità che conoscono la lingua. Oltre alle funzionarie vere e proprie vi
sono altre deportate che occupano posti di lavoro ambiti, come le addette alle
docce, quelle che lavorano nei magazzini, nelle cucine, nei servizi stabili
del campo e le artigiane. Il resto della popolazione è costituito da una massa
fluttuante di proletariato e sottoproletariato. Il proletariato lavora nelle
aziende agricole, nelle fabbriche , nei laboratori, nei
magazzini.
La classe operaia rappresenta la classe
produttiva. Il lavoro estenuante in fabbrica, la mancanza di riposo e di
sonno, l’alimentazione insufficiente e il freddo distruggono facilmente le
energie delle operaie-schiave, ma questo non costituisce un problema, perché
la forza lavoro è rinnovabile all’infinito. Non conviene creare migliori
condizioni di vita per le operaie, perché ogni miglioramento incide sui
profitti. Quando le operaie non possono più produrre si selezionano e si
inviano in trasporti neri alla camera a gas: così si eliminano le bocche
inutili e si creano posti per le forze fresche, che continuano ad arrivare al
campo.
Con l’inizio del ’44 le SS iniziano
deportazioni più massicce. Mentre il numero delle deportate aumenta in modo
vertiginoso, i posti di lavoro rimangono pressoché uguali e le richieste di
manodopera ristagnano. Ravensbrück si trova così con migliaia di schiave in
eccedenza. Si crea così un sottoproletariato, una classe miserabile, sporca,
pidocchiosa, coperta di stracci, destinata a diventare in brevissimo tempo
materiale da distruggere,
da eliminare.
Fanno parte a sé i neonati e i bambini. I primi nascono qui da donne che
arrivano incinte, gli altri giungono con le madri. C’è una sala parto. Dal
’42, quando lo scopo del campo diventa il rendimento, le donne incinte sono
obbligate ad abortire perché la gravidanza non disturbi la produzione.
L’aborto è praticato fino all’ottavo mese e il feto viene bruciato in una
stufa. Dal ’43 le gestanti possono continuare la gravidanza e partorire, ma i
neonati vengono subito strangolati o annegati in un secchio davanti alla
madre. Poi cambiano ancora le disposizioni: i neonati possono vivere, ma
niente è predisposto per permetterne la sopravvivenza. Se la madre sopravvive
alle infezioni, deve arrangiarsi da sola. La morte di questi bambini, che
sopraggiunge sempre dopo alcuni giorni, è ancora più triste delle piccole
vittime strangolate o affogate.
Nella nostra società gli anziani e gli inabili si emarginano, a i Ravensbrück
invece si ammazzano. Si usano i trasporti neri.
Nell’estate del ’44 l’avanzata dell’armata sovietica in territorio polacco
costringe i nazisti a trasferire i deportati dei campi dell’est verso i campi
dell’ovest. Arrivano tra il 2 e il 30 agosto quattordicimila polacche da
Auschwitz e subito dopo alcune migliaia di donne evacuate da Varsavia. Vengono
cacciate come bestie sotto un’enorme tenda militare, perché nei blocchi non
c’è più spazio. La tenda inghiotte una marea di donne sfinite dal viaggio,
sporche, pidocchiose, assetate e affamate. Scoppiano le epidemie e la
dissenteria miete più vittime della camera a gas; il forno crematorio viene
potenziato, con una terza bocca. La tenda- strumento di sterminio per morte
naturale- funziona per tutto l’autunno. Per mesi ho visto le deportate sparire
sotto quella immensa cupola. Nessuno è in grado di dire quante vittime abbia
ingoiato la tenda. Tuttavia essa non risolve ancora il problema, non è un
mezzo razionale di eliminazione di tutte le inabili e le malate. Svolge la sua
funzione senza regolarità e troppo lentamente. Si pensa di applicare
l’esperimento della tenda su scala più vasta, viene vuotato un campo di
rieducazione a due chilometri da Ravensbrück e il luogo diventa un campo
parcheggio in attesa della morte per le deportate anziane, malate, inabili al
lavoro. Le deportate vengono alloggiate mille per baracca, senza servizi
igienici, sono subito messe a mezza razione di viveri e obbligate ogni giorno
ad appelli di cinque, sei ore, con 20° sotto zero. Sono private di calze,
maglie, sciarpe, maglie, pezze per i piedi. A mano a mano che muoiono vengono
sostituite da altre. A febbraio viene costruita una camera a gas, per
accelerare i tempi. A febbraio nel campo ci sono 46.000 deportate e ai primi
di aprile ve ne sono 11.000.
Il 26 aprile il primo gruppo di deportate inizia l’evacuazione tra le strade
della Germania sconvolta e distrutta. Molte marceranno per più di 200
chilometri prima di essere liberate. Il 30 aprile le truppe sovietiche
liberano il campo dove sono rimaste solo le malate gravi.
Il Lager ha bisogno, per funzionare, di alcuni servizi essenziali. La cucina è
unica per tutto il Lager. Il lavoro in cucina è trai più ambiti, ma per
arrivarci bisogna godere di alcune protezioni.
Il Ravier è l’ospedale del campo. Vi si può essere ricoverate solo quando si
ha la febbre superiore a 39,5° o quando esiste un sospetto di malattia
infettiva. Al blocco 10 sono ricoverate le tubercolose e quelle considerate
pazze; al blocco 9 quelle affette da ferite purulente, da piaghe incurabili,
da foruncolosi, lo chiamano il blocco del pus; al Revier 2 le affette da
malattie infettive, vi sono ammassate, insieme, le malate di tifo, di
scarlattina, di colera, di difterite, nessuna precauzione igienica è osservata
per evitare il contagio: i gabinetti sono in comune, il termometro, le gamelle
e i bicchieri sono comuni. Il Revier dipende direttamente da un medico capo SS
e da alcuni suoi collaboratori specializzati in settori particolari:
sterilizzazione, aborti, selezioni, esperimenti chirurgici. La sala operatoria
all’inizio è usata per
far
abortire
le tedesche che hanno concepito con uomini
di razza inferiore. Successivamente serve per far abortire tutte le
prigioniere che arrivano incinte per poterle sfruttare immediatamente in
fabbrica. Serve anche per sterilizzare donne e bambine zingare, per impedire
la riproduzione di quel gruppo etnico. E soprattutto vi si compiono
esperimenti chirurgici su cavie umane. La storia di uno di questi esperimenti
è nota: durante il ’42 una settantina di donne polacche, tutte giovani e in
perfetta salute, sono trasferite al Revier e sottoposte ad interventi agli
arti inferiori. Dalle loro gambe sono prelevate porzioni di muscolo, ossa,
nervi e nelle ferite sono iniettate colture di bacilli diversi. Le operate
restano lì per mesi, fra sofferenze atroci, e sono sottoposte a cure con
medicinali diversi, spesso inutili, a volte mortali, oggetto di interesse
"scientifico” da parte dei loro torturatori. Quando l’interesse finisce le
poche sopravvissute, con le ferite ancora aperte e purulente, sono dimesse e
sistemate al blocco 32.
Nel campo si muore anche di “morte naturale” con una facilità estrema. La
fame, le carenze alimentari, il freddo, la mancanza di sonno, i parassiti, la
promiscuità, il lavoro forzato producono malattie, malattie che non producono
febbre alta e quindi non danno diritto di essere curate al Revier. Sono stata
ricoverata al Revier due volte. Una volta un mese per un paratifo. Sono
vissuta in mezzo a compagne malate di tifo, varicella, risipola, colera. Non
ho ricevuto cure di nessun tipo. Ho visto morire attorno a me quasi tutte le
mie compagne. Ogni mattina prima dell’ora dell’appello portavano via i
cadaveri e ogni giorno i letti vuoti si riempivano di nuove malate. Le
dottoresse e le infermiere erano prigioniere, ci trattavano bene, anche con
dolcezza. È al Revier che sento parlare per la prima volta dei trasporti neri,
ma non credo ancora all’esistenza della camera a gas, o almeno non voglio
crederci.
Vicino all’ingresso principale ci sono gli uffici amministrativi, l’anagrafe,
l’ufficio del lavoro e l’ufficio politico, dove lavorano deportate che
conoscono il tedesco. Essendo a contatto con i trasporti in arrivo, possono
ricevere notizie sull’andamento della guerra, su quello che avviene oltre il
campo, spesso hanno la possibilità di leggere giornali. È attraverso questo
canale che le deportate ricevono le notizie che corrono di blocco in blocco,
di Kommando in Kommando. Le notizie dall’esterno servono a mantenere viva la
speranza, a stabilire contatti tra le deportate. Alcune impiegate approfittano
della loro posizione per aiutare le compagne, avvisano quando ci sono le
selezioni nei blocchi o sul lavoro, alterano i registri sostituendo il numero
di una morta con quello di una viva per salvare deportate destinate ai
trasporti neri o alla fucilazione. Restano comunque una classe privilegiata
che non si mescola con il proletariato e il sotto proletariato e difficilmente
subiscono il processo di disumanizzazione; loro, non dovendo lottare per
sopravvivere, possono pensare, riflettere, continuare a resistere, rimanere
persone. Non ho mai conosciuto deportate degli uffici. Le ho viste soltanto e
le ho invidiate.
Nella città concentrazionaria non è
previsto il cimitero.
C’è un forno crematorio. È in muratura, all’inizio ha due bocche, ma nel ’44 è
potenziato con una terza bocca. Il camino, a partire dall’estate del ’44, fuma
giorno e notte; sulla cima brilla una fiamma verdastra e il vento porta fino
al campo l’odore della carne bruciata e scorie e cenere che cadono addosso.
Anche il Bunker, la prigione del campo, è una costruzione in muratura, di due
piani, con tante celle piccolissime, alcune senza finestra. Nel Bunker vengono
rinchiuse le sabotatrici, le grandi resistenti, le condannate a morte, quelle
che hanno tentato di evadere. Nel Bunker avvengono gli interrogatori, le
torture, le punizioni corporali. Accanto al Bunker vi è il corridoio delle
fucilazioni.
Lo Strafblock invece ha una funzione di rieducazione delle ribelli con metodi
e tecniche esemplari. Vi finiscono le prigioniere che hanno compiuto atti di
indisciplina, che hanno rubato, che si sono ribellate. Basta un niente per
esservi trasferite. Vi regna una disciplina assurda, assicurata da Aufsherin
sadiche e violente e da cani affamati e inferociti; le condizioni di vita sono
impossibili per la sporcizia e i parassiti; le ospiti devono svolgere i lavori
più assurdi e odiosi, come la “colonna di merda”: pestare gli escrementi con i
piedi nudi o impastarli a mano con la cenere del crematorio per ricavarne un
ottimo fertlizzante.
Il servizio di nettezza urbana funziona con un Kommando di spazzine armate di
scopa e carretti. All’esterno dei blocchi ci sono i bidoni della spazzatura,
ma nei blocchi del sottoproletariato sono sempre vuoti: noi non abbiamo niente
da buttare, non possediamo niente.
Tutti gli altri servizi che si trovano di solito in una città qui non possono
trovare spazio. È una città organizzata
in funzione della produzione e non può lasciare spazio per quello che non è
trasformabile in lavoro produttivo.
Arbeit,
lavoro, è una delle prime parole della lingua tedesca che le deportate sono
costrette ad imparare. Il lavoro inizia con la sirena del campo che dà la
sveglia, molte ore prima del levare del sole, e continua per tutto il giorno.
Quando finisce l’appello, tutte le deportate non in quarantena devono recarsi
sulla Piazza del Lavoro. A mano a mano che i Kommando che lavorano all’esterno
sono al completo, si avviano a passo di marcia nella botte verso il loro
cantiere, la loro fabbrica, il loro posto di lavoro, sorvegliate da cani che
ringhiano, dalle Aufsherin che urlano, da soldati SS che sfogano la loro
rabbia. Il Kommando più numeroso lavora alla Siemens. L’orario di lavoro è
uguale per tutte: dalle 6 del mattino alle 6 di sera, con una pausa brevissima
per la zuppa di mezzogiorno, che si consuma in piedi e all’aperto. Molte
deportate che arrivano a Ravensbrück sono inviate dopo la quarantena in
“trasporto”, cioè vendute alle industrie tedesche che ne fanno richiesta.
Alcuni di questi Kommando offrono alle detenute condizioni di vita migliori;
ma vi sono anche Kommandi infami: per esempio nelle officine sotterranee
costruite in una miniera di sale, o nello scavo di macerie nelle città
bombardate.
L’industria tedesca si serve a piene mani di schiave del serbatoio di
Ravensbrück. I padroni delle fabbriche vengono spesso di persona a scegliersi
le schiave. Quando poi la fatica, il freddo e al fame rallentano il
rendimento, le rimandano al campo, a “riposarsi”.
Io, dopo vari lavori di corvée in campo, ho fatto parte del Kommando
Planierung, addetto a spianare le dune per il sottocampo Siemens. Per
settimane ho spalato sabbia, ho spinto vagoncini sulle rotaie, ho posato
traversine e spostato rotaie.
Poi sono adocchiata dalla Kapo che comanda la Kolonne delle scaricatrici dei
battelli. Usiamo per il lavoro delle specie di cassette munite di quattro
stanghe. Alcune deportate riempiono le cassette, altre trasportano i carichi
dal lago al campo. Spesso piove, si scivola, e quando si versa il contenuto,
dopo le frustate regolamentari per “sabotaggio” bisogna raccoglierlo con le
mani fino all’ultimo pezzo. In tutte queste manovre a volte si riesce a
strappare con i denti qualche foglia di cavolo o a dare un morso a una carota
piena di terra. La fame è più forte della paura della diarrea, del mal di
stomaco, del tifo. Nella cattiva stagione si lavora con l’acqua alle caviglie
e l’acqua è sempre più fredda. Durante il giorno il vestito s’inzuppa e rimane
bagnato anche la notte perché non posso spogliarmi. Vivo nel blocco 23,
strapieno di prigioniere in quarantena, provenienti da Auschwitz, sono
miserabili più di noi.. al blocco 23 il letto è un’illusione, si cerca solo di
conquistare uno spazio per stendersi a dormire. La lotta per un posto scatena
scene di violenza bestiale. In questa situazione non è possibile spogliarsi.
Dormo per settimane con il vestito bagnato addosso. È il periodo in cui non mi
lavo più. A stento faccio la coda alla latrina. Mi trovo addosso i primi
pidocchi. Imparo a non pensare più per non sprecare energie, smetto di sperare
nella liberazione e di sognare la notte. Cado sempre più in basso, ho fame, ho
freddo. Odio e invidio tutte quelle che hanno qualcosa più di me….E
tuttavia non so rassegnarmi a morire.
L’istinto di sopravvivenza mi dice che se voglio salvarmi devo uscire dal
blocco 23 e trovarmi un lavoro al coperto. La Siemens diventa la mia
ossessione, il mio pensiero dominante: diventa l’ultima ancora di salvezza. Mi
vesto con un vestito a righe rimasto in un armadio, gli scucio il numero
vecchio, lo sostituisco con il mio, e me lo infilo sugli stracci. Ondina fa
altrettanto. Il vestito a righe è importante, permette di andare a lavorare in
Kommando stabili, è un segno di distinzione perché non denuncia a prima vista
la condizione di sottoproletaria. Io e Ondina ci infiliamo nelle Kolonne e
andiamo alla Siemens…ma il nostro colpo di testa non è riuscito, il piano è
fallito, ci riconducono al blocco. Ma dopo pochi giorni chiamano i nostri
numeri e raggiungiamo le Kolonne Siemens.
Entriamo, questa volta ufficialmente, in fabbrica. È la prima fabbrica che
vedo e mi dà un senso di angoscia, con tutte le donne vestite a righe chine
sul lavoro, l’Aufseherin che passeggia nel corridoi centrale con il frustino
in mano, il passo cadenzato, lo sguardo truce, alla ricerca delle più lente,
le sabotatrici. Passo la prima giornata a saldarmi le mani, a pasticciare con
lo stagno, a tentare di attaccare i fili con la bobina, ma concludo ben poco.
Nonostante l’insuccesso mi assumono perché la mia compagna di destra, una
danese che non ho mai visto prima, salda anche per me, e la sera la mia
cassetta è piena di bobine. Nei giorni successivi imparo il mestiere.
Il lavoro in sé non sarebbe pesante, sono le condizioni in cui lavoriamo che
lo rendono tale, sono le ore di lavoro, i ritmi, la denutrizione. Le
Aufseherin sono responsabili della disciplina. La direzione e l’organizzazione
tecnica del lavoro dipendono invece dal personale civile. Il lavoro si svolge
in due turni: dodici ore per il turno di giorno e dodici ore di notte. Giorno
e notte le schiave lavorano a pieno ritmo, senza tempi morti, nemmeno per
andare alla latrina. È proibito anche parlare con le vicine, se le deportate
sono sorprese a chiacchierare vengono punite, a schiaffi quando va bene,
oppure con la privazione della zuppa di mezzogiorno o del pane della sera.
Punizioni più gravi sono riservate a quelle che non producono abbastanza e
quelle sorprese a compiere atti di sabotaggio. È considerato sabotaggio anche
la rottura di una macchina che si spezza per usura o difetto di produzione. La
deportata che lavora alla macchina è ritenuta responsabile e punita, a volte
anche con l’impiccagione. Esiste anche il sabotaggio volontario, quando la
schiava coscientemente e metodicamente rovina i pezzi e li rende inservibili.
Anche il furto di pezzi di filo, di fogli di carta, di strofinacci è
considerato sabotaggio, ma questo è il tipo di sabotaggio che fanno tutte. È
considerato sabotaggio anche qualsiasi forma di solidarietà tra compagne.
Aiutare le compagne a sopravvivere a
danno della produzione, per il sistema è sabotaggio grave.
A Siemens quasi tutte le deportate hanno lo stesso aspetto, a cui io cerco di
uniformarmi. Esiste un’unica classe sociale, la classe proletaria, tutte
lavorano in fabbrica, hanno lo stesso orario e lo stesso tipo di trattamento.
Qui finalmente ho la possibilità di incominciare a conoscere qualcuna, di
sentirmi parte di un gruppo. Ho un letto stabile, ho un pettine, una matita,
ago e filo. Le francesi all’inizio sono dure con me. Per i loro gusti sono
ancora terribilmente sporca e soprattutto non mi perdonano di essere italiana,
tuttavia mi sopportano e mi trattano correttamente. Quando capiscono che sono
stata con le formazioni partigiane si sgelano, cambiano atteggiamento, mi
interrogano, si informano, vogliono sapere. Non mi considerano più un elemento
estraneo. Monique mi spiega perché lavarsi, pettinarsi e tenersi in ordine fa
parte della Resistenza in campo.
Lavarsi, smacchiarsi il vestito, lavare mutande e camicie, stenderle ad
asciugare, anche se è proibito, vuol dire
trovare la forza di rompere, di violare gli ordini assurdi del sistema.
Allenare la memoria e il cervello è un altro mezzo per resistere alla
disumanizzazione.
Mi costringe a disegnare, a scrivere,
sollecita i miei ricordi, mi fa parlare di casa mia, della mia terra, delle
mie montagne, mi riabitua alla conversazione. Soprattutto mi insegna i
principi che regolano la vita comunitaria del campo. Imparo che nel campo si
può rubare, ma solo al sistema. Si deve lavorare il meno possibile in
fabbrica, ma non si può sfuggire alle corvée, perché sennò ricadono sulle
spalle di altre compagne. Si deve rispettare il proprio turno per la zuppa e
la latrina. Adeguarmi alla sua linea mi fa fatica all’inizio, ma poi
incomincia a farmi piacere, riacquisto il rispetto di me stessa. Giorno per
giorno miglioro, riprendo a pensare, a parlare, a discutere. La speranza del
ritorno riprende da questo momento, anche se le mie condizioni di salute
peggiorano di giorno in giorno, l’avitaminosi mi ha colpita alle gambe, ho
piaghe che non guariscono e si allargano sempre di più, ho una tosse
insistente.
Risale a questo periodo anche la mia prima formazione politica. Ascolto
discussioni su Marx e sul marxismo, su Lenin e Rosa Luxemburg. Ascolto l’altra
campana sulla guerra di Spagna. Discutiamo anche sul comportamento delle
politiche del campo. Per molti mesi parecchie di loro hanno rifiutato di
lavorare per l’industria bellica e volontariamente hanno preferito i lavori
della Verfugbar a quelli della fabbrica. Solo quando la scelta è stata tra
vita e morte hanno seguito il consiglio delle più anziane e sono venute a
lavorare alla Siemens. Io sono felice di essere arrivata al coperto e non mi
pongo problemi di coscienza. Incomincio a capire che hanno ragione, ma non
rimpiango la mia decisione: non ho la stoffa dell’eroe. E non tornerei
indietro per nessun principio e nessun ideale.
I rapporti tra deportati e civili avvengono solo durante le ore di lavoro e
rispettano la scala gerarchica. Le operaie hanno rapporti solo con il
caporeparto. Il civile esegue solo le istruzioni avute dai superiori, i civili
che lavorano in fabbrica si attengono ai regolamenti, evitano i rapporti con
le detenute e fingono di non vedere le loro condizioni. I “padroni” non
compaiono mai sul posto di lavoro, vivono lontani. Come sempre i veri
responsabili si accontentano di tirare i fili e al momento della resa dei
conti lasciano i burattini a fare da capri espiatori. Quasi nessuno di loro è
salito sul banco degli imputati, durante tutti i processi contro i criminali
nazisti le responsabilità degli industriali volutamente non sono venute fuori.
Parlare della responsabilità degli industriali voleva dire andare alle radici,
fare il processo al capitalismo, trascinare sul banco degli imputati persone
“rispettabili”, uomini in doppio petto intenti a rimettere in piedi le
fabbriche, a ricreare una Germania economicamente potente. Si è preferito far
credere che i campi di sterminio fossero esclusivamente fabbriche di morte,
costruite per portare a termine la “soluzione finale del problema ebraico”.
Si è taciuto che il campo di sterminio è
stato soprattutto un sistema di sfruttamento di tutta la forza lavoro
concentrazionaria-
antinazisti, resistenti, ebrei, zingari e
altri. Le fabbriche tedesche che si sono servite di tale manodopera sono state
altrettante camere a gas al rallentatore.
Le deportate proletarie e sottoproletarie non ha rapporti diretti con la
classe dei “signori”, con le alte gerarchie SS del campo. La maggioranza dei
“signori” vende, seleziona, sevizia, ammazza a tavolino, cioè ordina de
vendere, selezionare, seviziare, ammazzare. Così l’odio delle deportate,
invece di rivolgersi contro i veri responsabili, colpisce solo gli esecutori,
le Aufseherin, le Kapo, sono loro che picchiano, urlano, frustano, sono loro
che si attirano l’odio feroce delle detenute, come i poliziotti di tutto il
mondo. Ho avuto rarissimi rapporti con le Aufseherin, ho imparato fin dai
primi giorni a evitarle come la peste, a nascondermi al loro passaggio. Le
Aufseherin sono l’unica categoria delle SS che vive a contatto diretto con le
prigioniere e le Kapo, le blockowe e le stubowe sono le loro dirette
collaboratrici.
Le punizioni, la paura delle punizioni, sono l’ossatura del sistema. Ogni
azione, anche la più banale, è in teoria passibile di punizione, perché nel
campo tutto è proibito: i pidocchi, il vestito sporco, il pezzo di carta sul
petto, la maglia sotto il vestito, il sacchetto per gli effetti personali sono
proibiti; sono proibiti la preghiera, la riunione di gruppi, il canto, la
conversazione; è proibito accoccolarsi all’appello, sorreggersi tra compagne,
sporcare la latrina, strascicare i piedi, stendere la biancheria, passeggiare
per le strade del campo, frugare nei bidoni della spazzatura, bere ai
rubinetti. Azioni che un giorno sono lecite possono diventare illecite il
giorno dopo. Le punizioni individuali vanno dalle scudisciate e dagli schiaffi
ai 25 colpi ufficiali di bastone o di nerbo di bue. Invece la punizione
collettiva, che può colpire le deportate di tutta una Stube, blocco o kommando,
oppure anche di tutto il campo, può limitarsi a un prolungamento dell’appello,
può arrivare alla privazione di acqua e cibo per giornate intere. La paura
della punizione collettiva dovrebbe, secondo i piani, dar vita a una specie di
spionaggio collettivo. Questo però non è avvenuto così spesso come il sistema
aveva previsto. Raramente si arriva alla denuncia della responsabile. Così il
sistema non
raggiunge l’obiettivo
che si è proposto.
Le deportate non sono disposte a
divenire spie o aguzzine.
La punizione collettiva peggiore che ho subito è stato l’appello di punizione
del 1° gennaio ’45. Siamo rimaste in piedi sotto la tormenta, in un giorno
freddissimo, sorvegliate dai cani, per più di 12 ore, solo alle 6 di sera
possiamo rientrare, ma la punizione continua per altre 48 ore con la
privazione del pane e della zuppa. Il motivo della punizione è stato tra i più
banali: una deportata, nella notte, non è riuscita ad arrivare al bugliolo e
ha sporcato fuori dalla porta dello Stube.
Le SS cercano di domarci e dominarci con leggi e punizioni disumane. Noi, da
parte nostra,
abbiamo come fine ultimo la
sopravvivenza e
sappiamo che per sopravvivere
dobbiamo imparare a violare tutte le leggi del sistema.
La violazione della legge inizia con l’appello. All’appello è proibito
parlare, e invece, sottovoce, corrono le notizie su quello che succede
all’esterno e all’interno del campo. L’appello è il giornale clandestino
parlato del mattino. All’appello è proibito muoversi, ma come le Aufseherin
girano gli occhi ci freghiamo la schiena l’una con l’altra. Abbiamo il petto
coperto di carta rubata in fabbrica, abbiamo rubato gli stracci per farci
fazzoletti, copricapi, paraorecchie.
Le infermiere rubano i guanti dei medici SS e ne fanno tettarelle per i
neonati, le lavoratrici del Betrieb rubano stoffa e ritagli per vestirli. A
natale la Stube delle francesi organizza una festa.
Mara sabota i condensatori. Pina inceppa la sua macchina. Io imparo a saldare
male per produrre bobine che si rompono subito.
Ogni giorno, ogni minuto, in ogni settore del campo le deportate infrangono la
legge ed ogni giorno la legge incassa un colpo. Non ha tenuto conto
dell’infinità capacità di ripresa della persona umana.
L’8 aprile compio vent’anni. È una domenica, c’è il sole. Un’olandese mi porta
in dono un pezzo di miele. Bice mi scrive gli auguri sul mio libriccino.
Il 26 aprile usciamo, come sempre, all’appello. Alla fine dell’appello la
blockowa dà l’ordine di rimanere tutte all’aperto: usciremo dal campo e ci
consiglia di portare con noi tutto quello che abbiamo perché probabilmente non
ritorneremo più. Esco con tutto il mio niente: il pettine, il pezzo di sapone
che mi ha regalato Bianca, i libretti di appunti e di disegni e una coperta.
Questa coperta mi seguirà per tutta l’evacuazione e per tutto il viaggio di
ritorno. L’ho ancora a casa.
Quando ho superato la porta del campo e ho cominciato a camminare mi sono resa
conto che forse avevo lasciato Ravensbrück definitivamente, ma che questo non
voleva ancora dire libertà. Marciamo a colonne di duecento, trecento, senza
sapere cosa vogliono fare di noi. Siamo ancora guardate da SS, basta uscire
dalle file per essere azzannate dai cani. Camminiamo per giorni interi per
strade gremite da uomini e donne in fuga, passando in paesi deserti,
completamente abbandonati. Abbiamo camminato per circa nove giorni. Ho il
ricordo della pioggia, del freddo, della fatica, forse anche della sete, ma
più di tutto dei bombardamenti e dei mitragliamenti. Abbiamo sempre dormito
all’addiaccio. Le scarpe mi hanno fatto uscire le vesciche nei piedi, ho
dolori alla gamba insopportabili. Pina a ogni sosta passa il suo tempo a
massaggiarmi la coscia e il ginocchio.
Quando la colonna si disperde, Pina e io ci troviamo sole, vestite a righe in
mezzo a gente civile. Abbiamo fame. A poche passi due uomini stanno addentando
voracemente pezzi di carne. L’odore della carne ci fa impazzire, ci dà
allucinazioni. Ci avviciniamo: parlano piemontese. È la fine della fame e
della solitudine. Mangiamo con loro, dividono con noi i loro vestiti.
Camminiamo per giorni e giorni mangiando patate.
…….
Bianca Paganini Mori
Con il nostro trasporto eravamo arrivate nel campo al numero 77500. Io ebbi il
numero 77399.
Ogni tanto chiamavano: “Bisogna andare a passare la visita”. Nude! Per farci
esaminare magari le mani e gli occhi. A casa ci avevano insegnato che neanche
ai fratelli ci si poteva presentare in sottana, e lì invece nude, di fronte a
tutti. Nude al freddo, sotto il nevischio, quegli uomini che ci guardavano,
non come donne, ma come lavoratrici.
Si lavorava sei giorni alla settimana per dodici ore, la domenica c’erano i
lavori extra, questi lavori erano spesso inutili, servivano per tenerci
occupate, forse per debilitarci di più. A loro non interessava che le
lavoratrici fossero sane ed efficienti, in Germania c’erano milioni di
deportati in eccedenza, noi eravamo
manodopera che poteva essere facilmente sostituita,
che si poteva perciò trattare male, quando non servivamo più potevano
eliminarci e si procuravano altri schiavi.
Nasce sempre la solidarietà tra coloro che
soffrono, fra coloro che sono costretti
a vivere in un inferno. A volte gli oppressi si scatenano contro gli altri
oppressi, ma lì non vidi mai fatti del genere. Era una solidarietà fatta di
poco, magari di un gesto, una parola, un cucchiaio di minestra.. era
soprattutto una solidarietà di
sentimenti. Solidarietà era anche
parlare alla vicina di lavoro e interessarsi a lei, era aiutare la compagna
che non riusciva a eseguire bene un legamento, era, infine, non fare la spia.
La paura della selezione era in noi tutte. Essere selezionate significava
finire nei trasporti neri e noi, se è vero che non pensavamo all’avvenire,
però in fondo non volevamo nemmeno morire, e cercavamo di tutto per non
morire.
Era proprio come se la mia mente, per la fame forse, non potesse più
ricordare. Ero come una bestia. Soffrivo
terribilmente, ma il passato non esisteva
più. Il presente era la sofferenza stessa. Il futuro non c’era: non saremmo
più andate via dal campo. Ogni giorno
vedevamo morire centinaia di persone, ogni giorno il forno crematorio bruciava
tanto che la cenere si posava dappertutto. E l’odore, l’odore dei morti
bruciati.
Ancora oggi io devo ricevere i danni di guerra. E l’Italia è l’unica nazione
che non ha dato una pensione agli ex deportati.
Io dicevo un giorno a una classe che la donna fu la linfa della Resistenza,
senza la donna la resistenza non ci sarebbe potuta essere. Gli uomini si sono
dimenticati che alle loro spalle c’era tutto un mondo di donne che lavorarono
accanto a loro e per loro e che pagarono allo stesso modo.
A Ravensbrück fra noi donne sapemmo trovare l’unione e anche la capacità di
resistere e di opporci. Ci fu chi venne fucilata perché si era opposta in
maniera aperta e chi faceva resistenza passiva: non lavorare o lavorare male o
lentamente. Riuscimmo anche a non
dimenticare di essere donne, e ci sforzavamo di tenerci pulite il più
possibile.
Però devo dire anche questo: trovai nelle donne che ci comandavano una
cattiveria spinta all’eccesso, forse maggiore di quella degli uomini. Quelle
donne, poste in una condizione e in ruoli maschili vollero essere, anche nel
male, uguali agli uomini, in realtà furono peggiori di loro.
Livia Borsi Rossi
Mio padre lavorava nella compagnia lavoratori del porto: scaricava carbone.
Hanno cominciato le prime organizzazioni degli scaricatori. Facevano le
riunioni per organizzarsi e per metter su le cooperative. Lavoravano 12 ore al
giorno in fondo alle stive e quando tornavano a casa la sera non trovavano più
nemmeno i loro bambini, che dormivano già. Ma si sono organizzati e hanno
fatto degli scioperi. Uno sciopero è durato, mi pare 60 giorni. Era il 1902:
io ero in fasce. Mio padre era un socialista, ma un socialista un po’…un
socialista vigoroso, ecco. Ci ha insegnato tante cose della lotta, che ne ha
fatta tanta, pover’uomo! io lo stavo ad ascoltare e sentivo di essere nata
proprio per la lotta: te lo conficcano nella testa e non puoi cambiare.
Nel ’25 mi sono sposata, anche mio marito era socialista e faceva lo
scaricatore di porto. Io ho smesso di lavorare perché lui non voleva. Nel ’28
ho avuto un maschio, il mio Ernesto,, nel ’30 la mia Adele, che è morta nel
’45, e poi nel ’32 l’altra bambina, Gemma.
Nel ’41 mi hanno fatto un processo e dovevano mandarmi al confine, ma poi mi
hanno assolta. Sono anche venuti in casa, i fascisti, ma non hanno mai trovato
niente.. e parlavo, parlavo sempre, contro il Fascio.
Avevo cominciato a portare munizioni. Da casa mia, passando sotto il naso ai
tedeschi, portavo queste munizioni a casa di uno e andavano a finire in mano
ai partigiani di città, ai gappisti.
Una sera picchiano alla porta di casa e mi cercano. Erano repubblichini. Hanno
preso me e mio marito. La Delina si è messa a gridare: “Non portate via la mia
mamma e il mio papà!”
La partenza è stata ai primi di ottobre. Eravamo centotrenta italiane. C’era
anche una donna vecchia, poverina. Portava, me la ricordo, una di quelle
sottane antiche tutte arricciate. Aveva dato da mangiare a dei partigiani e i
fascisti l’avevano arrestata. E siamo
partite. Ci hanno messe nei carri bestiame.
Siamo arrivate a Ravensbrück di giorno e ci hanno lasciate tutto il giorno
fuori. Poi ci hanno portate a dormire nella doccia e la mattina ci hanno
visitato, nude! Ci hanno fatto anche la visita interna e ci hanno messo nella
vagina della roba che bruciava dentro. Ci hanno guardato la bocca, i denti.
Tutte ci si aiutava l’una con l’altra, è adesso
che non ci aiutiamo più, che siamo venute cattive, ma nel dolore si sente
l’affetto e ci si aiuta.
Il campo dove mi hanno trasferita era a due chilometri dalla fabbrica dove ci
hanno mandato a lavorare. La fabbrica era enorme, in muratura. In quella
fabbrica facevano aeroplani. Lavoravamo 12 ore al giorno, ma c’erano anche i
turni di notte. La disciplina era dura. Fra noi non potevamo parlare, le
ausierke che ci sorvegliavano erano tanto cattive e ci voleva poco a prendere
un calcio nel sedere, io ne ho presi tanti!
A noialtre ritornare a Ravensbrück faceva paura: se non si lavorava ci
rimandavano lì.
Io avevo paura per la Delina, che era grande. Io non le avevo insegnato tante
cose, perché avevo paura a spiegarle le brutture della vita: non avevo mai
detto niente ai miei bambini dei pericoli cui andavano incontro, e per quello
avevo paura. Così dicevo a Sant’Antonio che li tenesse distanti dalle cattive
tentazioni. E pregavo santo Spedito: “Fate che finisca presto la guerra e che
ritorniamo tutti a casa”. Adesso non prego più, non posso più pregare la
Madonna, perché se a una ha fatto la grazia, come dicono, e a un’altra non
l’ha fatta, vuol dire che fa quello che vuole anche lei. In chiesa non ci vado
e non credo a quello che dicono i preti, perché sono falsi come Giuda. La mia
fede ce l’ho, ma me la faccio io, con la mia coscienza.
Non avevamo più le mestruazioni, nessuna le aveva più. Se capitava che
qualcuna vedeva un gocciolino di sangue, si metteva a ballare.
Le polacche in principio non ci potevano vedere noi italiane, perché dicevano
che eravamo fasciste. Poi abbiamo cominciato a far capire che eravamo delle
antifasciste e le polacche alla fine ci volevano bene. Io ho tante lettere
delle compagne di Varsavia che mi hanno scritto.
Mi hanno messa a pulire i cessi, a pelare le patate in cucina. E io rubavo.
Delle volte c’erano anche delle carote e io le rubavo e ne davo anche alle mie
compagne. Ultimamente da mangiare non ce n’era più, né patate né carote né
niente. Allora le polacche andavano a raccogliere le ortiche nei campi e
facevano un brodo di ortiche e rape rosse. Ma poi si correva al cesso, a me
cominciava a venire la diarrea, l’enterite.
Poi è venuta l’evacuazione, ci
hanno fatto marciare venti giorni. E se ci fermavamo caricavano subito il
mitra per sparare. Camminavamo tutto il giorno. Ci toccava anche spingere i
carretti.
…..Siamo arrivati a Genova. Avevo i pantaloni a righe dell’ospedale, la zebra,
un ciuffetto di capelli legati con lo spago, ciabatte di pezza tutta rotta, un
fagottino, e facevo pietà……Le donne mi dicono. “Livia, fatti coraggio, è la
Delina che è morta”. Io non ho visto più niente. Piangevo che credevo di
impazzire, di morire. Mia figlia Gemma, la più piccola, l’ho trovata che era
così grande. L’avevo lasciata piccola. Poi è venuto mio figlio e mi ha
abbracciato. Delina è morta da una pallottola fascista, in un grosso
combattimento mentre portava la roba ai partigiani.
Mio marito è morto in Germania, è stato a Flossenburg e a Hersbrück. So che
m’hanno detto che gli è venuto il tifo petecchiale, che è finito nel forno
crematorio.
Mi sono messa a lavorare alla San Giorgio: pulivo i cessi, pulivo gli uffici.
Non avevo forza., era poco che ero ritornata di là, sarò stata venti chili
quando sono tornata. Eppure avevo bisogno di lavorare. Questa è stata la
ricompensa che ho avuto; dopo aver aiutato la guerra di liberazione, questa è
stata la ricompensa. La ricompensa che hanno dato ai deportati.
E quando sono tornata, se raccontavo cos’era il
campo, mi guardavano come per dire: “Questa qui è scema, questa qui inventa”.
Questa è tutta la mia vita.
Lina e Nella Bronconi
Nella- io avevo 18 anni quando mi hanno arrestata, quindi una grande
preparazione politica non l’avevo. In famiglia eravamo tre figlie. I miei
genitori non erano sposati in chiesa. Mio padre era anticlericale. Nostro
padre veniva dalla campagna ed era un operaio. Per molti anni in tre andavamo
a scuola, e nostro padre era solo lui che lavorava.
Lina- durante la guerra eravamo impiegate. In contatto con i compagni siamo
entrate dopo l’8 settembre, per via di nostro padre. Papà era socialista dal
’20. Piano piano ci vennero i collegamenti.
Siamo state proprio noi ragazze che volevamo far
qualcosa. “Oh, mi piacerebbe fare la
staffetta e andare anch’io in montagna” dicevo.
Nella- noi facevamo lavoro di stampa. Battevamo a macchina i pezzi. Andavamo a
portare il materiale di stampa a Medicina, Imola, Ponte Ronca. Una volta
tenemmo delle armi in cantina.
Lina- la spiata a mio padre venne dal posto dove lavorava, all’Oare. Nella
perquisizione trovarono solo le macchine da scrivere, un pugno di manifesti e
della carta bianca.
Nella- quella mattina ci trovavamo a casa tutte e quattro, noi donne. Fui io
ad andare ad aprire la porta e vidi mio padre in mezzo a due SS.
Lina- ci fecero vestire, ci caricarono tutti insieme su una macchina grande e
ci portarono subito via.
Ci portarono al comando delle SS. Cominciarono gli interrogatori, giorno e
notte. Una volta mio padre lo torturarono tutta la notte, io ero nella cantina
chiusa, non vedevo niente, però sentivo. E loro mi vennero ad aprire la
cantina, mi presero e mi portarono davanti a lui, lui era là, non stava
neanche in piedi era buttato in terra che si lamentava, aveva la faccia
tumefatta, e tutto il corpo. Lo avevano denudato e gli avevano fatto certe
torture che hanno fatto anche gli americani nel Vietnam, l’avevano legato mani
e piedi e lo tiravano su e giù con una carrucola, su e poi giù di colpo, e lo
picchiavano sui genitali. Negli interrogatori picchiavano anche me, nelle
gambe, nella schiena. Volevano sapere chi dirigeva, i nomi, una cosa e
un’altra.
Un bel giorno i tedeschi decisero: mi portarono a casa a prendere della roba,
della biancheria. Forse era già deciso che ci avrebbero mandato in Germania.
Senza
processo, senza sentenza, senza dirci dove ci portavano, un bel giorno ci
fecero partire.
Siamo rimasti tre mesi in un campo di smistamento a Fossoli, tutti insieme.
C’erano già ebrei, anche loro famiglie intere, si aspettava.
Nella- nostro padre partì alla fine di luglio, con l’ultimo trasporto degli
uomini. E noi fummo l’ultimo scaglione di donne, il 2 agosto.
Lina- partimmo in camion aperti, noi quattro donne e c’erano altre famiglie,
ebrei. Noi siamo rimaste insieme, forse perchè eravamo politiche e le
politiche le portavano a Ravensbrück, mentre gli ebrei li hanno separati.
Abbiamo viaggiato 4 giorni, perché il 6 arriviamo a Berlino. Poi, sempre nello
stesso vagone, siamo arrivate direttamente a Ravensbrück.
Nella- ci misero dentro le docce. Quello che ricordo sono i cadaveri che
vedevamo
Lina- cadaveri viventi
Nella- scheletri con gli occhi fuori dalla testa. C’era qualcuna che andava a
cercare in mezzo ai rifiuti. Noi eravamo ancora ben pasciute. Sembrava una
cosa possibile che si dovesse arrivare a quel punto.
C’erano francesi, polacche, russe. Anche delle tedesche politiche. Io ricordo
quel periodo, che alla mattina dopo l’appello ci portavano per le visite
varie, nude, tutti i giorni. Guai se una teneva le mutande! Ricordo sempre la
mamma che, poveretta, si vergognava, tanto più che aveva una certa età e la
mentalità di una che viene dalla campagna. Poi, alla fine magari ci guardavano
soltanto la bocca.
Dopo la quarantena ci portarono nelle baracche definitive. Noi siamo riuscite
a rimanere insieme.
Lina- in principio non abbiamo trovato subito il posto da dormire. I castelli
erano di legno a tre piani, quelli da caserme insomma, in ogni piazza, che era
strettissima, avrebbe dovuto starci una persona, ma lì ce ne stavano due e
anche di più. I pagliericci erano mezzi vuoti e si stava sul legno,
soprattutto se si capitava nel punto dove due piazze si avvicinavano.
Nella- capitai in un castello di mezzo a tre piazze, erano già in sei e dovevo
far la settima. In quel castello c’era anche una Lagerpolizei. Faccio per
salire a mi sono sentita arrivare addosso un fracco di botte. Allora mi sono
messa lì in terra, accanto alla mamma.
Lina- i primo giorni c’erano queste difficoltà: si andava in un posto, non ti
volevano; si cercava da un’altra parte, ma era lo stesso.
Nella- noi non siamo mai state schizzinose e avevamo fame, ma la zuppa era
immangiabile, perché era fatta di rape legnose, conservate sotto terra, e poi
d’inverno gelate e bollite, senza sale.
La maggioranza erano cadaveri viventi. Quello che siamo diventate un po’
tutte, dopo.
Di biancheria mi ricordo che avevo solo un paio di mutande, e giravo con
queste mutande in mano, quando le lavavo, finché non si erano asciugate, o me
le mettevo da asciugare.
Lina- il tempo era passato e avevamo cominciato a cercare di procurarci
qualcosa da vestire. Lì si poteva solo col pane, al mercato nero del campo. Le
disgraziate compravano la roba col pane, l’unico pezzo di pane che ci davano.
Nella- io sapevo del Bunker. E mi ricordo di aver visto qualcuna con delle
grandi cicatrici alle gambe, e una senza una gamba, e mi dissero che erano
stati esperimenti che avevano fatto
Lina- molti trasporti li lasciavano anche all’aperto lungo il muro di cinta,
per giorni interi, ed era già freddo. Si sentiva anche sparare, dal tunnel
della fucilazione, che era tra le cucine e il forno crematorio.
Nella- la mamma negli ultimi tempi all’appello non si reggeva più in piedi,
fuori, con il freddo, non riusciva neanche a respirare. La blockowa cercava di
aiutarci e la fece prendere nell’infermeria, anche se non aveva la febbre. Una
sera siamo riuscite ad andare dentro a vederla, era in una cuccia lurida nei
castelli della fila di mezzo. Delirava. Ebbe un dolore fortissimo in un
momento, che poi le passò. E parlava, parlava, parlava, in fretta, a scatti.
Ma ci riconosceva. La mattina dopo era morta. Le morte le ammucchiavano,
denudate, le buttavano su un carretto e le portavano via: quel carretto,
carico, che andava verso il forno crematorio, lo vedevamo sempre passare.
Aveva 51 anni perché era del ’93.
Lina- la Iole era anche lei in un’infermeria. Lei era molto affettuosa, molto
sensibile, molto emotiva. Perciò quando la mamma è morta non gliel’abbiamo
detto, e lei non lo ha mai saputo.
………..
Ci dissero che mio padre era partito in trasporto ed era finito nei forni
crematori. Con la Croce Rossa abbiamo poi avuto un atto di morte, con la data
della sua morte, il 3 gennaio.
Nella- La prima volta che sono andata a Mathausen, nel ’60, visitammo il campo
e poi ci portarono al cimitero e lì trovammo il registro. Sfogliando vidi:
“Baroncini Adelchi, morto al castello di Hartheim”.
Finché parlo con chi è stato nel campo, so che capisce quello che dico. Ma in
ufficio, per esempio, delle volte quando se ne parla, a parte il fatto che ti
compatiscono, ecco che penso: “ma come fanno a sapere, a conoscere a fondo
cos’era?”. E allora cerco di parlarne il meno possibile, parlo quando mi
chiedono, quando mi ci tirano.
La deportazione è sempre rimasta un po’ da
parte. E bisogna anche protestare
contro le cose false che si dicono della deportazione: a vedere certi film
pare che la deportazione delle donne sia stata andare a finire nei casini dei
tedeschi! Ravensbrück non era questo.
Lina- proprio le donne sono state meno riconosciute. È vero che ce n’erano di
meno, nella Resistenza, a dirigere, a organizzare, ma non a lavorare, a
aiutare.
Nella- e hanno pagato più degli uomini, forse più degli uomini.
Eppure al ritorno noi abbiamo trovato la
diffidenza perché eravamo donne.
Lina- facemmo la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità di
guerra. Ci mandarono alla visita all’Ospedale militare, e lì ti spogliavano
tra gli uomini, con i militari che entravano e uscivano. Mi dissero che ero
idonea a tutti i servizi, e mi risero anche dietro. Possibile che ai raggi non
si vedesse che avevo avuto una pleurite bilaterale?
Nella- io ho avuto l’invalidità di guerra. Ogni tanto vado al dispensario per
il controllo, e ogni volta fanno un sorrisino a sentire: partigiana
combattente.
Lina- ci capita di sentirci dire ancora adesso: “ma era vostro padre
partigiano, non voi”.
Nella- e invece no. non è stato nostro padre a chiederci di fare quel poco che
abbiamo fatto. Noi eravamo responsabili, avevamo deciso noi, spontaneamente.
Lina- Anche se non eravamo molto politicizzate, anche se era una scelta
emotiva.
E ci siamo anche sentite dire: “Ma voi non avete combattuto, non avete usato
le armi”.
Non abbiamo usato le armi, ma si combatte con tante armi: un manifesto, un giornale, uno scritto, anche una macchina da scrivere era un’arma.