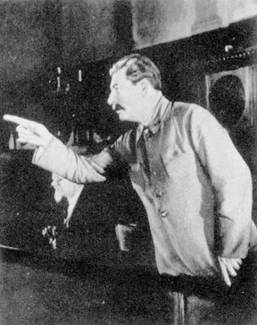La violenza illimitata
Pierre Hassner, coautore del
Libro nero del comunismo, in uno dei saggi contenuti nel volume sottolinea
che, “non si vuole sicuramente fare un confronto quantitativo delle vittime, né
negare l’unicità della Shoah, né sostenere che i campi sovietici avessero la
stessa finalità di sterminio o di disumanizzazione di quelli nazisti […] si
tratta piuttosto di interrogare la specificità e le differenze sulla base di una
problematica che non può non essere comune e non essere interamente ispirata
dallo sgomento dinnanzi a uno stesso fenomeno per quanto diverse ne siano le
modalità: il fenomeno della violenza illimitata.” Soltanto la comparazione
permette di far emergere l’unicità dei due orrori.
Proprio il concetto di violenza
illimitata rappresenta la chiave di lettura della comparazione, il terreno
comune tra nazismo e stalinismo. Lo Stato hitleriano e quello stalinista
rappresentano l’esito degenerativo del concetto di Stato.
Nato
dall’esigenza di tutelare la vita dei cittadini, lo Stato diviene nella versione
staliniana e hitleriana lo strumento di selezione
dei cittadini. Due
“mitologie” diverse che conducono ambedue a orrori innominabili. Sia lo
stalinismo che il nazismo ricorrono al concetto di
“purezza”
che per Hitler è sostanzialmente
biologico-razziale
mentre per Stalin è
ideologico.
Nell’uno e nell’altro caso non rientrare nei canoni della “purezza” significa
incamminarsi verso il lager o verso il gulag.
Ambedue i sistemi producono un “nemico
totale”:
per Hitler è l’ebraismo,
per Stalin il
capitalismo,
che rappresentano in entrambi i casi l’ostacolo
al raggiungimento della felicità,
che nel nazismo si identifica con la
purificazione
della
razza ariana
e nello stalinismo con la realizzazione piena del
socialismo.
Di
fronte a questo nemico i due sistemi elaborano in modo parallelo il rifiuto di
ogni barriera di umanità, di freno politico, etico, religioso.
Il
punto che avvicina gli orrori indicibili dei due sistemi sta nella
negazione dell’individuo
come valore,
dell’unicità della persona umana. Non c’è
spazio per il diritto del singolo né nello stato hitleriano né in quello
stalinista.
La violenza del comunismo sovietico
è, al contrario,
essenzialmente
interna alla società,
che cerca di sottomettere e disciplinare ma anche
trasformare e modernizzare con metodi autoritari, coercitivi e criminali; le
vittime dello stalinismo sono quasi tutte dei cittadini sovietici e ciò vale
sia per le vittime dei processi e delle epurazioni politiche, sia per le
vittime sociali.
La macchina del terrore aveva cominciato a
funzionare già con il primo piano di industrializzazione forzata; vittima
principali ne erano stati i contadini, ma non vennero risparmiati
commercianti, tecnici e dirigenti di partito accusati di sabotare lo sforzo
produttivo. Il periodo delle “grandi
purghe” ebbe ufficialmente inizio nel
1934, per poi susseguirsi ad un ritmo impressionante, giustificato dalla
necessità di combattere traditori e nemici di classe. Si trattò di una
gigantesca repressione poliziesca, condotta nell’arbitrio più assoluto, che
colpì milioni di persone e che diede vita ad un immenso
universo
concentrazionario formato dai campi
di lavoro (arcipelago Gulag).
In essi la violenza è legata ad un progetto di
trasformazione coercitiva e autoritaria della società.
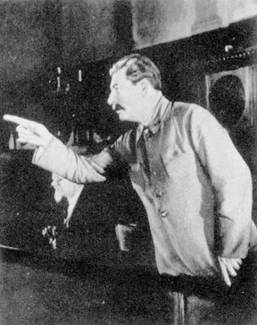
La violenza
del nazismo è essenzialmente
proiettata verso
l’esterno.
Dopo una prima, intensa ma rapida fase di “normalizzazione” repressiva della
società tedesca, la violenza nazista si scatena nel corso della guerra, a
partire dal 1939, come un’ondata di terrore né cieco né indiscriminato ma
rigorosamente codificato.
Praticamente inesistente nei confronti di una
comunità nazionale razzialmente delimitata e sottomessa, questa violenza
diventa estrema nei confronti di categorie umane e sociali escluse dalla
comunità del Volk
(ebrei, zingari, handicappati, omosessuali),
per estendersi poi alle popolazioni slave, ai prigionieri di guerra, ai
deportati antifascisti (in corrispondenza a una precisa gerarchia).
La persecuzione antiebraica infatti fu certo la
manifestazione più vistosa e più orribile di questa politica razziale, ma non
fu certo l’unica. Essa si inquadrava in un più vasto programma di
“difesa della razza”
che prevedeva, fra l’altro, la sterilizzazione
forzata per i portatori di malattie ereditarie e la soppressione degli infermi
di mente classificati come incurabili.
Per quanto invece riguarda specificatamente gli
ebrei, la propaganda nazista riuscì semplicemente a risvegliare quei
sentimenti di ostilità, contro la diversità etnico religiosa e contro il
presunto privilegio economico (essi infatti, pur non facendo parte della
classe dirigente tradizionale, occupavano le zone medio-alte della scala
sociale), che erano largamente diffusi, soprattutto nelle classi popolari, in
tutta l’Europa centro-orientale. La discriminazione fu ufficialmente sancita
nel settembre 1935 dalle cosiddette leggi di Norimberga, subì un’ulteriore
accelerazione a partire dal novembre 1938, soprattutto con la cosiddetta notte
dei cristalli e raggiunse il suo culmine a guerra mondiale già iniziata,
quando Hitler concepì il progetto mostruoso
di una soluzione finale
del problema che prevedeva la deportazione in
massa e il progressivo sterminio del popolo ebraico.
Tutte queste pratiche erano considerate dal
nazismo essenziali per mantenere la sanità e l’integrità del “popolo eletto”.
Il mito della razza occupò quindi un posto centrale nella teoria e nella
prassi del nazismo: il tratto demoniaco dell’esperienza stessa sta proprio
nell’avere eseguito questo mito con brutale coerenza.
Le camere a gas quindi, diversamente dai campi di lavoro,
esprimono la
forma dello sterminio come finalità in
sé,
inscritta in un disegno di purificazione razziale